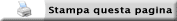|
Vent’anni di rivoluzione in tavoladi Tutto è iniziato nel 1994, quando un gruppo di famiglie di Fidenza si è organizzato per acquistare insieme prodotti biologici direttamente dal produttore. Era il nucleo del primo Gas, Gruppo di acquisto solidale, ufficializzato poi due anni dopo, "con quella S finale che segna l’inizio di una nuova azione collettiva che con la spesa promuove un altro modello di sviluppo", come spiegano Michele Bernelli e Giancarlo Marini in L’altra spesa, il testo base d’obbligo per chi voglia capire l’essenza diquesto mondo complesso e in continua evoluzione.
Da quel gruppo pioniere siamo arrivati oggi a milioni di persone coinvolte. Solo due anni fa un’analisi Coldiretti/Censis evidenziava come i Gruppi solidali di acquisto intesi nel senso più ampio "siano diventati un fenomeno di rilievo che ha contagiato il 18,6% degli italiani. Quasi 2,7 milioni di persone fanno la spesa con questo sistema in modo regolare". "In alcuni casi - sottolinea la Coldiretti - ci si limita solamente al cosiddetto ’carpooling della spesa’ con i partecipanti che di fronte al caro benzina si mettono in auto insieme per dividere i costi e andare a fare la spesa nei punti più convenienti, dalle aziende agricole ai mercati degli agricoltori, dai mercati all’ingrosso agli ipermercati, fino ai discount".
Un altro censimento necessariamente approssimativo, probabilmente per difetto, stima che di Gas veri e propri nel Paese ne esistono almeno mille, per un totale di circa 50mila famiglie coinvolte. Unacrescita che nell’ultimo decennio ha fatto registrare un robusto +40%). Rete Gas, il principale coordinamento dei gruppi esistenti, ne conta da sola 979 (circa 200.000 persone), ma ritiene che ce ne siano il doppio, non solo perché molti non si sono ancora presi la briga di segnalarsi, ma anche perché, a volte, il censimento registra solo la coordinazione locale di più gruppi contigui. Si concentrano ancora soprattutto al Centronord, anche se buoni esempi al Sud non mancano (in Sicilia si contano 15 gruppi, in Sardegna 8).
Successo numerico dunque, ma anche un crescente peso economico. Il sociologo Thomas Regazzola cita una ricerca universitaria pubblicata su Agriregionieuropa (anno 7 n°27, p. 80), dove si stima che ciascuno dei 90 Gas conosciuti di Roma avrebbe un fatturato annuo di 33.600 euro, cioè un flusso globale di 3 milioni all’anno. Un altro studio sulla provincia di Bergamo arriva alla conclusione che, rivolgendosi al sistema alternativo di "piccola distribuzione",i 60 Gas locali danno un contributo all’agricoltura contadina rispettosa dell’ambiente pari a 5 milioni di euro all’anno. Da parte sua, la struttura nazionale di coordinamento valuta la spesa familiare media, all’interno di un Gas, pari a 2mila euro ogni anno e stima che il fatturato dei gruppi locali superi, globalmente, i 90 milioni.
Ma più dei numeri imponenti e dell’impatto economico di tutto rispetto che il proliferare dei Gas è riuscito ad ottenere in questi primi 20 anni, il risultato forse più duraturo e sorprendente è stato quello di aver saputo trasformare una bella esperienza da idealisti in mainstream, di essere riuscito ad imporre il marchio del km zero, pur con tutte le sue ambiguità, come un valore aggiunto, costringendo la grande distribuzione, non da ultima la Coop, spinta anche dall’onda lunga dei Gas, a documentare online in maniera dettagliata la filiera dei prodotti presenti sui suoi scaffali. In breve ad adattarsi. Un vasto indotto, dai Farmers Market alleesperienze di "confine" come La Zolla di Roma, ha poi tratto beneficio dalla battaglia culturale iniziata 20 anni fa quando il primo gruppo di acquisto solidale creato da un pugno di famiglie di Fidenza di giorno va in giro a bussare alla porta dei piccoli produttori agricoli della zona e di sera, attorno a un tavolo, definisce i criteri su cui fondare la propria attività.
Il gruppo mette così su carta le prassi appena sperimentate, nascono i principi fondamentali che diventeranno comuni a ogni gruppo: la partecipazione attiva di tutti i soci, le filiere corte, l’incontro diretto tra produttore e consumatore. "Non ricordo come - racconta Mauro Serventi, uno dei protagonisti di quella esperienza - ma i tre aggettivi che orientano l’azione dei Gas, piccolo, locale e solidale, sono venuti a galla un po’ così, ragionando sulle nostre pratiche spontanee".
Un importante salto di qualità si registra nel 1998, quando si svolge il primo incontro nazionale e si gettano lefondamenta per la carta costituzionale dei Gas, il "Documento base", approvato l’anno successivo e basato sui principi chiave elaborati dai "fondatori" di Fidenza. Intanto i Gas, dal congresso del 2005, cominciano a parlare di grandi numeri. Nello stesso anno si supera quota 200 gruppi. Lo Stato si accorge di loro e cerca di fissarne i contorni nella Finanziaria del 2008, definendoli "Soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun incarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita".
La marea montante del movimento, così spontanea e capillare, è in realtà difficile da imbrigliare in definizioni e regolamenti. La prima e più banale classificazione è quella in micro e macro, che riguardal’ampiezza dei gruppi. "La tendenza prevalente è quella di chiudere il numero a 25-30 nuclei familiari", dice Paolo Menchini, del Gas Massa. Sono rarissimi i gruppi che superano i 100 nuclei aderenti. Ma in questa galassia c’è posto anche per l’ipertrofia che ha assunto il "Rigas" di Rimini: 100 famiglie nel 2005, 450 nel 2007, fino alle diverse migliaia di oggi. Man mano che il Gas cresce vengono attivati nuovi punti di ritiro dei prodotti, in pratica dei sotto-gas. I produttori hanno a che fare con oltre 40 referenti.
Il Rigas è certo un modello distante dal principio del "piccolo è bello". Ma l’unione fa la forza e nella sua carica di aggregazione può parlare da pari a pari con i poteri forti della politica locale e sviluppare progetti da grandi numeri che fuoriescono dal limitato ambito dell’agro-alimentare per sconfinare in altri settori decisamente più impegnativi: sono nate esperienze di coproduzione per proteggere la biodiversità, il paniere si èallargato ad abbigliamento e servizi come la telefonia e le energie alternative (grazie ai Gaf per l’acquisto di pannelli fotovoltaici), si progettano i Des, i Distretti di economia solidale, dove far confluire tutte le realtà di consumo critico sul territorio. E c’è anche chi ha messo in cantiere i Gat, con l’obiettivo ambizioso di comprare terreni su cui far crescere i prodotti del Gas.
Ogni volta che compri, voti. È questo il filo che lega insieme le diverse pratiche di consumo critico. Come già accennato, a rendere unica questa esperienza tutta italiana, che ha le sue radici nell’associazionismo, è quella S finale che mette la solidarietà prima di tutto, anche del risparmio. Solidarietà con i fornitori e con i piccoli produttori biologici strozzati dai grossisti, ma anche all’interno del gruppo, dove ci si dividono compiti e organizzazione. È un movimento cresciuto fuori dai modelli tradizionali, senza una struttura decisionale accentrata, ma che in rete si scambia idee esuggerimenti, lancia progetti e affronta le contraddizioni.
In questi primi venti anni di vita "l’altra spesa" dei Gas è cresciuta. Ma bisogna sfatare alcune false leggende. Le riunioni dei Gas possono trasformarsi a volte in sedute più tese e logoranti di quelle di un condominio. Inoltre i gruppi non sono cenacoli di gastronomi in cerca di prelibatezze, ma gruppi di persone normali che nella vita di ogni giorno vogliono mangiare, vestirsi, pulire la casa meglio e in modo più equo. Acquistano direttamente dal produttore, perlopiù a chilometri zero, e accorciano la filiera, riducendo all’osso gli intermediari. Non per questo sono pauperisti, ma vogliono promuovere la riconversione di un modello economico distorto, irrazionale e spesso sprecone.
Se la platea sempre più ampia ha in parte annacquato la purezza degli ideali, nella sua composizione più genuina i Gas non sono gruppi di risparmio a caccia di saldi e convenienze: si guarda al costo solo dopo aver guardato a tutto ilresto. Il prezzo di un prodotto deve essere prima di tutto pulito, giusto, trasparente. Non vogliono far politica, dicono. Ma la fanno tutti i giorni usando il potere della spesa. Si definiscono "consum-attori", nel senso che non subiscono i consumi ma ne diventano i protagonisti grazie a scelte precise.
Orgogliosi della loro identità fluida, anche i Gas oggi si trovano a dover fronteggiare la crisi economica e cercano nuove forme di organizzazione. Se ne è parlato in un convegno che si è tenuto a giugno a Collecchio, organizzato proprio in occasione del loro ventennale. Il titolo scelto è emblematico: "Il colpo d’ali". Quali sono dunque le strade nuove da percorrere? "Il tema emerso - ci spiega ancora Serventi, storico ’gasista’ di Fidenza - è la presa di coscienza che il nostro è sì un mondo dinamico, ma troppo frastagliato. Quello che manca è un soggetto di sintesi, che permetta all’economia solidale di integrarsi in maniera omogenea con il territorio. Ma una soluzione l’abbiamotrovata - continua Serventi - Il prossimo 18 ottobre a Parma apriremo il ’Tavolo della Rete di economia solidale’, al quale parteciperanno tutti i soggetti attivi in questo tipo di economia alternativa. Sarà un organismo che avrà il compito di coordinare i singoli progetti e rappresentare l’economia sociale e solidale in maniera unitaria". E il 23 luglio scorso la Regione Emilia Romagna ha approvato una legge per tutelare lo sviluppo dell’economia solidale, la numero 19 del 2014. Al comma 4 dell’articolo 1 vengono indicati gli elementi su cui si sviluppa l’economia solidale, è il riconoscimento ufficiale dei principi che venti anni fa ispirarono la nascita dei Gas.
Una battaglia di civiltà
Vent’anni di Gas dimostrano che un altro sistema di distribuzione del cibo è possibile. Ci fanno capire come ampie fasce della popolazione italiana (ma possiamo ben dire mondiale, se consideriamo esperienze analoghe - ma non uguali - come le Amap francesi o le Csa statunitensi)desiderino accorciare la distanza, fisica ed empatica, che li separa dai luoghi di produzione del proprio nutrimento.
Una distanza che, se è troppa, comporta svantaggi per sé, per la propria famiglia, per la propria comunità, per l’ambiente e per i produttori stessi. Sembra l’uovo di colombo: unirsi per risparmiare in emissioni, risparmiare denaro, procurarsi ingredienti freschi, di stagione, di provenienza certa e verificabile. Eppure da molti questa possibilità è ancora percepita come un esperimento appartenente al mondo degli "alternativi", magari un po’ radical chic, magari un po’ troppo fissati con il cibo.
Chi ha già sperimentato l’acquisto diretto presso i contadini - tramite i Gas o recandosi in azienda, al mercato dove ci sono o in altri modi perché le possibilità sono davvero tante oggi - però sa che la cosa funziona molto bene e rende tutti soddisfatti. Chi si è avvicinato a questo mondo sa che non ci sono fasce di popolazione particolari che lo sperimentano: la cosaoggi coinvolge a tutti i livelli, anche insospettabili.
Forse saranno meno contenti del successo di questa diffusione coloro che organizzano forme di distribuzione più centralizzate e omologanti, ma il fatto stesso che negli ultimi vent’anni la proposta nei supermercati o centri commerciali sia in parte (o molto) mutata in favore dei prodotti locali, con una più chiara dichiarazione di origine, attraverso nuove linee che vanno incontro a queste esigenze dei consumatori, è li a dimostrare che i nostri acquisti hanno un potere pesantissimo e che alla lunga sono davvero in grado di cambiare dei sistemi che a prima vista paiono incrollabili.
Ho usato la parola consumatori: ho fatto male. È brutta e ha una connotazione fortemente passiva, che riguarda sia il ruolo di chi compra quanto il "consumo" di ambiente e risorse connessi ad acquisti disinformati e poco sostenibili. Da tempo propongo di sostituire la parola con "co-produttori" (c’è anche chi propone consumattori o altro), ma nonè una mera questione semantica: diventare co-produttori significa trasformarsi concretamente in soggetti attivi che esercitano tutto il loro "potere della spesa" attraverso l’educazione, l’informazione e infine le proprie scelte; in cittadini consci che mangiare deve essere l’atto ultimo di un lungo processo di produzione-distribuzione virtuoso che non si appoggia e prolifera speculando sulle distanze tra i suoi terminali, ma li avvicina per formare una rete unita nel perseguire obiettivi di sostenibilità, qualità, giustizia. E questo significa cambiare prima se stessi: ecco cos’hanno fatto per vent’anni gli aderenti ai Gas e tutti quelli che con loro condividono questa battaglia di civiltà, anche in altri modi, diversi e creativi, e che sarà dura contrastare nel suo lento ma sicuro incedere.
"Modello da seguire anche per noi della Coop"
Claudio Mazzini è il responsabile sostenibilità di Coop Italia. Coop è marchio leader nella grande distribuzione organizzataitaliana con il 15,3% del mercato davanti a Conad e Selex. Ha un fatturato di 12,7 miliardi di euro, mille e duecento punti di vendita e 54mila 700 addetti. È presente capillarmente sul territorio dal nord al sud del Paese ed è anche una rete di imprese che appartiene a oltre 8 milioni di soci, in crescita del 3,4% rispetto al 2012.
Venti anni fa sono nati i Gruppi di acquisto solidale. Sembravano un’utopia oggi sono diffusi in tutto il Paese e la loro filosofia di acquisto ha fatto breccia. Ne siete stati influenzati anche voi come grande distribuzione?
"Le posso fare una battuta? Noi siamo il più grande Gas d’Italia con milioni di soci. Certi connotati dei Gruppi di acquisto, la filosofia di fondo, i valori, sono gli stessi nostri valori. Anche noi abbiamo un codice per la scelta del produttore, anche noi cerchiamo di favorire il commercio equo e solidale. Lo sviluppo dei Gas non può che farci piacere, perché la diffusione di questi valori così diventa sempre più ampia,capillare".
Insomma quale è stato l’impatto della diffusione dei Gruppi di acquisto?
"Quella dei Gas è un’esperienza importante, di grande stimolo per noi. Il fenomeno in questi anni si è sviluppato ed è cresciuto molto, anche se, a quanto risulta, numeri ufficiali non ce ne sono. Difficile dire quale sia stato l’impatto reale sull’economia. Certo c’è stato un impatto sulla consapevolezza dell’acquisto, sui comportamenti etici. Le iniziative dello scorso anno sulla produzione di agrumi hanno spinto a una verifica sul campo anche se era un settore che stavamo monitorando dal 2009 come dal 2005 operiamo un controllo diretto sulle aziende che producono pomodori. Noi l’attività dei Gruppi di acquisto solidale la seguiamo con attenzione perché è il nostro compito di guardarci attorno, e se è il caso copiare o reinventare. Inoltre il fatto che i Gas seguano principi e regole che sono simili alle nostre è per noi motivo di orgoglio".
La filosofia di fondo è la stessa?
"Lafilosofia di base è mettersi insieme per ottenere le migliori condizioni. È la ricerca di un prodotto che sia etico, buono, conveniente. I prodotti a marchio Coop devono contenere valori che non sono negoziabili e sono fonfamentali. Per questo dico che la filosofia dei Gas ci assomiglia molto".
Negli anni si è venuti a parlare sempre di più di "chilometro zero" è merito dei Gas?
"Chilometro zero è uno slogan di una importante associazione di agricoltori. Io dico che più che chilometro zero bisogna guardare a chilometro vero. Il gioco di parole sta per la vera questione: accorciare la filiera il più possibile. I Gas, come noi, possono anche distribuire ai soci prodotti che vengono da lontanissimo, che so i clementini dalla Calabria, ma l’accorciamento della filiera fa sì che il prodotto sia di qualità e remunerativo per chi compra e chi produce. Perché il rischio è che i produttori, schiacciati dalla filiera lunga, smettano di produrre".
Nei Gas conta molto il legame con lastagionalità.
"Ecco questo è l’altro punto in cui noi e i Gruppi di acquisto ci avviciniamo. L’educazione al consumo: frutta e verdura vanno mangiati quando è il loro momento, la loro stagione. Hanno anche un sapore diverso. E questo non dipende tanto dal fatto che siano coltivati vicino a te, quanto che siano accessibili direttamente. Io abito a Bologna, dovessi nutrirmi solo con quello che è coltivato vicino a me in certi periodi dell’anno avrei una dieta molto semplificata. Ma l’importante è che arrivino sulla mia tavola prodotti che sono di stagione in Italia, con l’accorciamento della filiera su ortofrutta e carni questo accade. E il risultato è mangiare prodotti più sani e anche più buoni. D’altra parte chiunque sia stato nei paesi tropicali sa che c’è una bella differenza fra i frutti mangiati dove vengono coltivati e quelli che arrivano da noi, fatti maturare nei container".
Alessandro Cecioni, Monica Rubino, con un commento di Carlo Petrini -repubblica
|