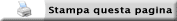|
Sono nati liberi e mercoledì 7 maggio voteranno per la prima volta. Sono la “generazione Mandela”, quelli venuti al mondo dopo le prime elezioni libere del 1994, oggi ventenni, che non hanno mai visto le durezze dell’apartheid ma conoscono fin troppo bene quelle della disoccupazione: uno su due non ha lavoro.
Disincantati, delusi e in larga misura disgustati dalla politica, dall’arroganza dei nuovi ricchi e soprattutto dalle ruberie di chi comanda; grati ai padri che hanno fatto “la Lotta”, The Struggle, come vengono chiamati i lunghi anni della rivolta, ma lontani da quella epopea. Studiati da vicino dagli istituti demoscopici, lusingati in tutti i modi dai partiti, è molto probabile che alla fine non vadano nemmeno a votare oppure scrivano sulla scheda un grande “No”, per esprimere il loro dissenso radicale. L’astensionismo giovanile non ha fatto che crescere di elezioni in elezione, nulla induce a pensare che quest’anno sia incontrotendenza.
Quanti sono, i “born free” sudafricani? Tanti, sicuramente. La società è giovane, giovanissima, come in tutta l’Africa, per l’effetto combinato dell’alto tasso di natalità e dell’accresciuta mortalità della generazione precedente a causa della pandemia di Aids: due terzi dei sudafricani ha meno di 35 anni. Per chi arriva dall’Europa fa sempre impressione: è facile sentirsi vecchi a Johannesburg. I nuovi elettori che si sono registrati quest’anno sono 2,3 milioni. Circa il 10 per cento del corpo elettorale. Si metteranno in coda insieme agli altri, nel ventesimo anniversario della liberazione sudafricana, per la prima volta senza l’incombente presenza, la guida ideale di Nelson Mandela, morto a 95 anni nel dicembre scorso. Quale sarà la loro scelta politica è un mistero.
I vent’anni trascorsi dal 27 aprile 1994, quando per la prima volta i sudafricani di ogni razza e colore votarono insieme, sono stati un lungo, progressivo ritorno alla realtà. Un ritornodapprima stupito, poi amaro, infine sempre più arrabbiato. Le grandi promesse di giustizia sociale non si sono realizzate. I poveri sono rimasti poveri, i ricchi sono diventati sempre più ricchi. I salari sono aumentati meno del costo della vita, le bocche da sfamare sono più (molto più) dei posti di lavoro.
La scolarizzazione è cresciuta ma il livello dell’istruzione pubblica è crollato. I servizi di base lasciano molto a desiderare - l’elettricità, per esempio, in molte parti del Paese va e viene - e dove sono rinnovati ed efficienti sono spesso troppo cari. La libertà di parola è garantita ma il monopolio del potere politico-economico è stretto nelle mani dell’oligarchia targata African National Congress. Le statistiche dimostrano che la società sudafricana è oggi più diseguale di quanto non fosse alla fine del regime dell’apartheid. Insomma, per molti aspetti un fallimento. Dice Lisa Nene, 22 anni, che vive in una baracca a Durban: «Dalla generazione dei nostri genitori abbiamoricevuto soltanto mezza libertà».
La Mandela generation, come ovunque accade con i giovani, vola troppo basso per essere intercettata dai radar sociologici. Chi sono gli under 20 di Soweto, la più grande metropoli del Sudafrica? Quelli che ingannano la noia facendo train surfing, lo sport più pericoloso del mondo, consistente nello stare in piedi come su una tavola da surf su un convoglio ferroviario lanciato a piena velocità, a rischio della vita? O i The Soil, gruppo musicale a cappella di tre voci straordinarie dallo stile fusion complesso e inconfondibile, tutti intorno ai vent’anni? O gli Smarteez, giovanissimi pazzi stilisti, anch’essi in numero di quattro, che si definiscono «collettivo di moda fai-da-te» e che altri hanno chiamato «tribù fashion», e dispongono per tutto apparato produttivo di una macchina da cucire? Disperati o creativi, o tutte e due le cose insieme, un po’ speranzosi e un po’ cinici? Probabilmente più simili ai nostri figli di quanto non vorremmoammettere, perché metropolitani, urbani, connessi, frequentatori di centri commerciali e di fast food, cittadini del mondo. Ma anche africani, svelti, musicali, infinitamente inventivi, avvezzi a vivere con poco, molto poco, dipendenti dalla solidarietà del gruppo, istintivamente sorretti dalla fede.
Molti che hanno avuto l’occasione di frequentarli, specie educatori, docenti, preti, ne hanno descritto la lontananza dai valori della generazione precedente. Una professoressa venuta dall’Europa ha scritto che per loro Mandela, quand’era ancora in vita, era già una figura lontana, remota, di un’altra epoca. Un inviato del “New York Times” ha scoperto una ragazza, vicino a Johannesburg, che adora l’afrikaans, l’idioma dei bianchi sudafricani, un tempo considerato la lingua degli oppressori. La grande rivolta di Soweto del 1976 scoppiò contro l’imposizione dell’insegnamento obbligatorio in afrikaans a scuola. Ma la diciottenne Nokhutula Magubane oggi dice: «In fin dei conti è solo unalingua. Ed è così bella». Commenta Akhumzi Jezile, 24 anni, nota personalità televisiva: «Non è che non capiamo cosa sia stato l’apartheid; è che i nostri problemi sono diversi».
Prendiamo la casa, per esempio. Tutti quei milioni di ventenni ne sognano una per sé, ma l’offerta è spaventosamente inferiore alla domanda. È una della tante (delle maggiori) promesse non mantenute da vent’anni di governo dell’African National Congress, uno dei problemi sociali diventati cronici attraverso quattro successive elezioni. Poi sentono una qualunque radio, cliccano un sito di notizie o un social network, e sentono parlare dello “Nkandlagate”. Nkandla è un paesotto del KwaZulu, noto per essere il luogo natale del presidente Jacob Zuma, che alle prossime elezioni briga un secondo mandato (anche se il capo dello Stato viene scelto indirettamente, dal Parlamento appena eletto).
A Nkandla, Zuma ha una proprietà, costituita da una casa e alcune costruzioni all’interno di un vasto terreno, di cuipoco dopo la sua elezione fu avviata la ristrutturazione. A spese del contribuente. Costo totale, riveduto al rialzo: 16 milioni e mezzo di euro. Una cifra iperbolica, ma in termini sudafricani addirittura incommensurabile. I lavori prevedono una piscina, un auditorium, diverse case per le numerose mogli del presidente.
Lo sdegno è stato universale e Nkandla è diventato Nkandlagate. In marzo il “public protector” (figura di difensore civico prevista dalla Costituzione), la coraggiosa Thuli Madonsela, ha presentato un rapporto di 400 pagine che è un devastante atto d’accusa contro Zuma. L’African National Congress ha gestito la vicenda, in corso ormai da anni, nel modo peggiore possibile. Ha negato; ha detto che la ristrutturazione era motivata da considerazioni di sicurezza; ha cercato di opporre il segreto di Stato per impedire che i progetti architettonici venissero resi pubblici; ha screditato e minacciato la Madonsela in modo indegno; infine adesso, in campagna elettorale,risponde a chi l’incalza che «basta parlare dello Nkanlagate, occupiamoci piuttosto dei problemi della gente».
«Se non è un problema della gente questo!», obiettano i suoi avversari, il cui numero non fa che crescere. Almeno due nuovi partiti sfidano l’Anc, con credenziali inoppugnabili agli occhi di settori diversi dell’elettorato, specie giovanile: uno è fondato da un demagogo estremista di trentatré anni, cacciato dai ranghi del partito; l’altro da una donna che è una figura storica della lotta anti-apartheid. Ma, fatto ancor più grave, lo abbandonano personalità eminenti che ne sono sempre stati al fianco o alla guida. Come l’anziano arcivescovo Desmond Tutu, già fraterno amico di Mandela, il quale ha annunciato pubblicamente che non voterà per l’Anc. O Ronnie Kasrils, compagno della prima ora oggi settantacinquenne, vecchio combattente, dirigente del partito, ex ministro, che ha lanciato la campagna “Vukani! Sidikiwe!”. Che vuol dire: “Svegliatevi! Siamo stufi!”. PietroVeronese,l’espresso
|